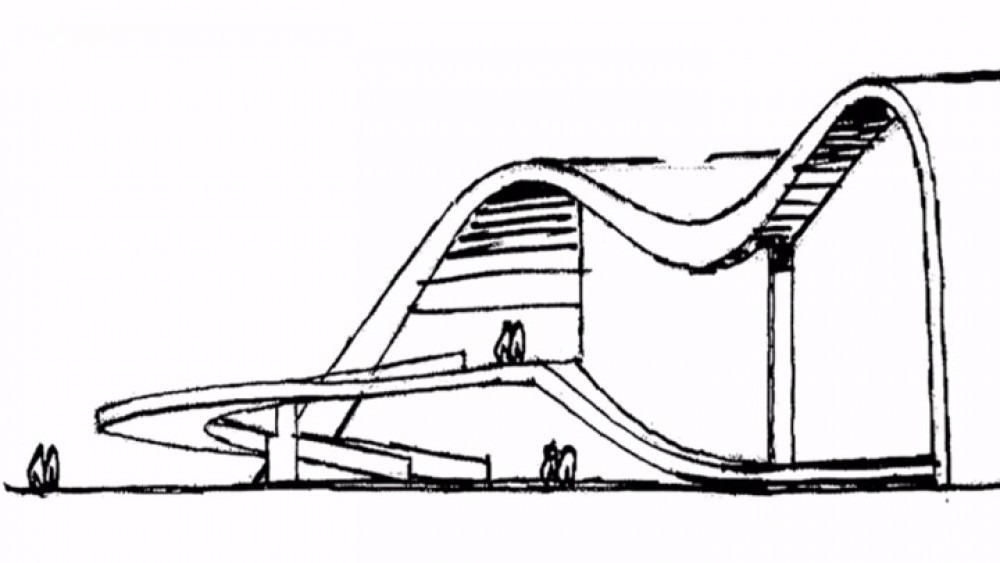Perché c’è Michael Keaton, sul palcoscenico, del tutto a caso? Non era neanche nel cast. Che ci fa? Forse vi starete chiedendo questo. Immagino, che vi starete chiedendo questo. C’era scritto tutt’altro, sulla locandina. Io non ero previsto. Avete ragione voi e io probabilmente ho torto. Ho torto a stare qui, non c’entro nulla, voi avete pagato per altro. Avete pagato per vedere “Il giardino dei ciliegi”, di Čechov, con Jeremy Irons. Che è stratosferico, tra l’altro. E’ l’evento dell’anno! Voglio dire, Playboy…- e non mi guardate così, perché sapete perfettamente che Playboy ha una delle pagine culturali più autorevoli di questa nazione. Dicevo, Playboy l’ha paragonato a nomi del calibro di Kenneth Branagh o Laurence Olivier quando fanno o facevano Shakespeare. E voglio dire, Čechov è pure un russo perdio! Quanto è bravo Jeremy Irons…no? Quanto è bravo lui, quanto è bravo Kenneth, quanto era bravo Laurence, quanto è bravo Anthony Hopkins. Tutti britannici, ovviamente.
Che bello, essere britannici e attori. Anch’io sono attore, bé, ma questo lo sapete…sì peccato che io sia americano. Noi attori americani abbiamo fondamentalmente quattro nomi: Tom, Kevin, Matt, Michael. Abbiamo la mascella grossa, recitiamo in film da duri nei quali ci si spara spesso, si guidano macchine veloci e si mangiano abbastanza cheeseburger. E comunque in media siamo considerati ben più scarsi dei nostri colleghi del Vecchio Mondo. I cari e vecchi britannici…già. Come Jeremy Irons, appunto, sublime, nel fare Čechov.
L’ho visto qua dietro, dietro le quinte. Jeremy Irons, intendo, certo non Čechov. Ma questo voi lo sapete già, e probabilmente il fatto che io l’abbia voluto specificare lo ritenete insultante, offensivo, svilente. E anche in questo caso non avreste affatto torto. E vi starete anche innervosendo, perché non vi ho ancora spiegato perché io sia qui. E già lo sapete che in realtà io sto prendendo tempo.
Però sì, vi devo delle spiegazioni, siete già stati troppo clementi, nel non farmi allontanare dal palco a suon di fischi e verdura. Qui a Broadway il pubblico è esigente e io lo so, lo so bene.
Insomma, è successo questo: passeggiavo attorno al teatro oggi pomeriggio – non ricordavo neanche ci fosse lo spettacolo – quando d’improvviso incrocio Jeremy. La nostra amicizia ci lega da decenni, la nostra stima reciproca poi. Così abbiamo iniziato a parlare e niente, mi ha chiesto di partecipare. Sì, stasera: di salire sul palco, di aprire le danze. Di venire a raccontarvi cosa sia, davvero, per me, in fondo, tutto questo. Tutto questo cosa? L’essere attore. E ora vi sarà anche più chiaro il mio tentennamento, questa paura, questo spreco di tempo. Perché in fondo io non so cosa dirvi. Non so neanche se merito, tutto questo. Non so se l’ho mai meritato.
Io recito, ok? Io recito, sono un attore. Sono un attore perché quando ti va bene ti pagano. Ti pagano bene. Avete idea di quanto io abbia ricavato da “Batman”? No perché io no. Non lo so. Ed è bello: sinceramente, è una gran bella cosa. E poi perché l’attore…l’attore è una persona che non esiste. O meglio, noi esistiamo attraverso persone perlopiù inesistenti. Noi attori ci svegliamo la mattina e sappiamo di esserci perché alcuni di noi sono stati Batman, alcuni Joker, alcuni Two-Face. Alcuni sono stati assassini, alcuni sono stati altri attori, alcuni presidenti, alcuni amanti, alcuni fondatori di una catena di fast food, alcuni capi delle guardie, alcuni sogni, alcuni robot. Vi chiederete allora se tutto questo, in fondo, è così bello. Se ne vale la pena. E’ quasi un controsenso, se ci pensate, trovare una ragione di esistere nell’inesistente, non è vero? E’ che, in tutta sincerità, è un gran bel casino, ma molto, molto divertente. E poi se ti va bene, ti va bene parecchio. Chiaro no?
Tutto qui. Basta così. A voi tutti, buona serata.
E comunque vaffanculo Jeremy Irons.
Pierpaolo de Flego