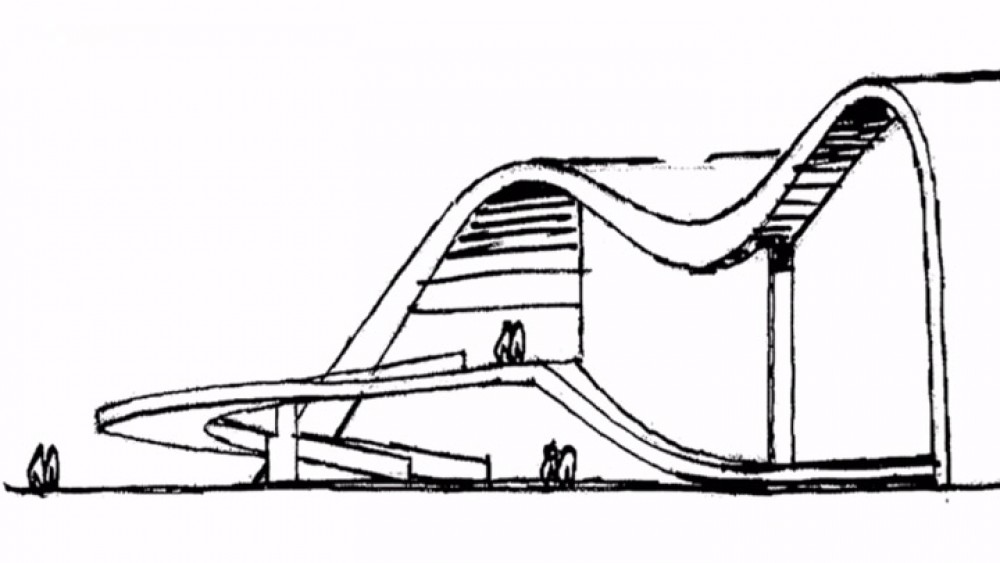Di Stefano sua madre diceva sempre che era uno preciso. Fin dall’inizio. Fin dalla scuola elementare. Metodico. Di mente matematica, diceva lei. Faceva i compiti scegliendo sempre lo stesso ordine di materie, metteva i quaderni e i libri nella cartella con rigore chirurgico. “Dovrebbe fare il chirurgo”, lo diceva sempre sua mamma. Avrebbe voluto che l’unico ometto di casa (suo marito e padre di Stefano era andato a cercare fortuna in Sud America poco dopo la sua nascita. Avrebbe voluto portarci poi tutta la famiglia. L’ultima lettera a casa, dopo mesi di silenzio, diceva “E’ successo un guaio. Sono in Venezuela e mi hanno arrestato. Non so che ne sarà di me”. Poi più nulla) diventasse qualcuno che conta. Qualcuno che avrebbe fatto la carriera vera. Un medico, un chirurgo, un primario stimato. Ma Stefano il suo metodo l’aveva sempre voluto mettere nelle costruzioni, devolverlo al concreto, ai bulloni, all’assemblaggio pesante. Era un mago quando aveva in mano il Lego. “Che diventi allora un architetto”, ribadì con gli anni la madre. Ma lui si iscrisse all’istituto tecnico industriale. Il suo intento era che fuori dalla scuola sarebbe diventato meccanico e baci e abbracci alle stronzate di sua mamma.
“Per come è andata, forse avrei dovuto iscrivermi ad architettura”, pensò svogliatamente Stefano quella mattina, mentre aspettava che il Nescaffè si intiepidisse. Aveva un lavoro da fare, aveva già preso accordi da giorni. Era tutto calcolato al secondo. Il suo, per certi versi, poteva essere definito un lavoro a cottimo. Ma un cottimo a parecchi zeri. Servivano precisione, concretezza e poche parole: Stefano aveva trovato il suo.
Iniziava a fare freddo, era ottobre inoltrato, aveva scelto di uscire con l’impermeabile lungo e scuro: non che tenesse chissà che caldo, ma brezza fredda a parte la giornata prometteva un meteo sereno e terso, e lui sarebbe stato perlopiù al sole. Si mise gli occhiali scuri e uscì di casa. Era ampiamente in anticipo ma ne era consapevole: voleva passare alla Feltrinelli, stare un po’ lì, sfogliare dei libri. Lo faceva spesso, praticamente ogni giorno, indipendentemente se avesse il cottimo o altre commissioni da fare. Non gli era neanche di strada, ma non gli importava. Non gli era mai importato. L’appuntamento era fissato alle undici, lui entrò alla Feltrinelli che dovevano essere le dieci meno qualche minuto. Imboccò il piccolo corridoio centrale, iniziò a guardarsi attorno per capire quale direzione del fitto e labirintico ordine di scansie scegliere. C’era la letteratura straniera, le novità, la divisione per autori, la divisione per case editrici, poi la sezione dei gialli, a seguire la saggistica e la letteratura da viaggio. Non ci badò, leggeva i nomi delle sezioni in modo del tutto incosciente. Decise di fermarsi davanti a uno scaffale a caso. Era alto e ad angolo cieco, gli interessava quello. Prese in mano il libro più a portata di mano, si trattava di un romanzo di Paolo Sorrentino; gli fece strano, perché a quanto ne sapesse Sorrentino era un regista acclamato. Sfogliò un po’ di pagine, stava cominciando a leggere l’introduzione quando sentì la voce di Veronica alla cassa. Non aveva mai parlato con lei, un giorno però aveva scorto il suo nome sul cartellino che portava sulla camicetta di lavoro. Alzò furtivo la testa guardando in direzione della cassa. C’era già della fila, ma tra una nuca e l’altra il sorriso di Veronica si apriva alla sua maniera: dolce e malinconico, gentile e solitario, come se ci fosse qualcosa di più, una tristezza onesta di chi forse ha sempre qualcosa accanto che non è nascosto ma è invisibile, e che nessuno riesce e riuscirà a scorgere mai; una timidezza mascherata da imbarazzo, una solitudine elegante e talmente bella da sembrare non appartenere quasi a questo mondo. Quella mattina Veronica aveva i capelli sciolti: i suoi lunghi capelli castano scuri si abbandonavano a partire dal viso spigoloso sulle spalle, sui seni non poi così piccoli e lungo la schiena, si mimetizzavano a fatica sulla camicetta nera, si diramavano in quasi tutte le direzioni verticali del suo corpo asciutto e slanciato. Erano splendenti ma più mossi e disordinati del solito, segnale di una doccia fatta di fretta prima del turno. La gentilezza faceva da padrona in quei gesti ripetitivi e retorici, nel passare tra le mani ossute e armoniose libri o dischi o dvd o vinili o portachiavi di dubbio gusto, nelle buone parole sempre, negli occhi castani e rotondi che si aprivano giganti come pianeti a rischio di esplosione, in quel sorriso. In quel sorriso.
La suoneria degli sms accompagnò la vibrazione del vecchio Nokia 3310. Stefano chiuse il libro, lo rimise a posto e prese dalla tasca dei pantaloni il cellulare. Era un messaggio di R.. “Showtime”, diceva. Nient’altro. Era giunta l’ora di andare. Guardò l’ora, erano le undici meno venti. “Porca troia”, pensò. La fila si era diradata, perciò riuscì a imboccare velocemente il corridoio più diretto per raggiungere l’uscita.
“Un giorno dovrà pur comprare qualcosa. Se no poi penso che viene a leggere a scrocco!”
Una voce solare, simpatica, dolce, fece eco al passaggio di Stefano verso l’uscita: era passato davanti alla cassa e non se n’era nemmeno accorto. Stefano si fermò di colpo e si voltò in direzione di quella voce.
“No, mi scusi…mi scusi, non volevo…non era un apostrofarla, ci mancherebbe. Davvero…davvero, lei può venire quando vuole, è che è qui quasi ogni giorno e praticamente non l’ho mai sentita parlare e… e non so, mi aveva incuriosita e allora…ma mi scusi, davvero, non voglio esserle sembrata maleducata. Non era mia intenzione.”
Il viso di Stefano non doveva essere stato dei più rassicuranti, aveva anzi un misto di paura e agitazione sommessa. E a occhio, doveva aver spaventato anche un po’ Veronica, che con quelle parole stava tentando con onestà di scusarsi. Ma Stefano era bloccato, forse le ultime parole non le aveva neanche udite. Era rigido e instabile come un albero della cuccagna. Stava per aprire bocca, per dire qualcosa, ma esitò. Dapprima il suo viso assunse la forma di qualcuno che sta per piangere. Poi prese un respiro e disse: “Io…io devo andare”. Ma non lo disse, lo mormorò e basta. Furono le sue prime parole in quella libreria, negli ultimi quattro anni, sei mesi e tredici giorni.
Stefano uscì rapidamente dalla porta a vetri, era in ritardo per la prima volta in vita sua. Prese l’auto, c’era traffico in città, era sfinito. Non gli reggevano le gambe, ansimava, digrignava i denti, prendeva tutte le curve strette, prese anche un paio di marciapiedi, era completamente fuori giri. “Dai dai daiiiii!”, urlò in auto da solo, all’ennesimo rincoglionito che gli aveva fatto prendere un rosso. Quando finalmente arrivò a destinazione c’era E. ad aspettarlo: lo conosceva già, sembrava un bravo ragazzo. Era fuori dal portone di ingresso della casa in questione, e fumava con la valigia ai piedi. Già da lontano sembrava agitato, camminava nervosamente avanti e indietro e fumava: un tiro dopo l’altro, quasi non espirava, sarebbe potuto soffocare da un momento all’altro.
“Ma porca puttana, ma dove cazzo eri? Hai idea di quanto rischio il culo per te, pezzo di merda?”
“Buongiorno a te, E.”.
“Ma…ma vaffanculo! Che cazzo vuoi? E fortuna che tu sei sempre quello in anticipo. “Il migliore”, “Impara da lui che è il migliore sulla piazza!”. Ma fottiti, un cazzo il migliore”.
“E. vedi di stare calmo eh? Dammi la valigia”.
“Calmo una sega! Eccoti la valigia, migliore sulla piazza. Dopo manda un messaggio a…”
“A R.. E’ ovvio. Lo faccio da ben più tempo di te questo lavoro. Buona giornata.”
“Vaffanculo!”
Stefano non rispose più nulla. La valigia pesava e doveva arrivare sul tetto del palazzo. Ma ormai era abituato. Era anni che lo faceva quel lavoro. Man mano che saliva le scale si sentiva sempre più calmo: era un lavoro ad alto rischio ma lui era veramente il migliore sulla piazza. Ne aveva tentate molte, ma forse quello era l’unico lavoro in cui era davvero bravo. Era preciso, taciturno, concreto. Non doveva essere altro che se stesso. La porta che dava sulla terrazza del tetto del palazzo non era neanche chiusa con le chiavi: tanto meglio così. Stefano si guardò intorno, si orientò con l’ambiente. Palazzo Rinaldi era dritto davanti a lui, svettava sullo skyline con i suoi quindici piani di totale lusso. Tra lui e il palazzo c’erano due case sensibilmente più basse, a coprire la visuale sul marciapiede che gli interessava vedere. Ma per fortuna ad aiutarlo c’era Via Palladio, una strada abbastanza larga che divideva la zona in due isolati, creando lo squarcio necessario per la visuale perfetta. Stefano si appostò in linea d’aria con precisione chirurgica sull’asse centrale di via Palladio. Non si mosse più di un centimetro da lì. Mise i guanti in lattice che portava in tasca della giacca, aprì la valigia e mise in moto le sue abilità da meccanico. Per lui un fucile era come il Lego Technics. Lo montò in un meno di un minuto. Fissò il calcio e lo impugnò, in modo che il mirino cadesse perfettamente sulla stessa asse centrale di Via Palladio. Iniziò a guardarci attraverso. Passò più di un’ora: un altro aspetto fondamentale del suo lavoro era la pazienza.
Tutto a un tratto, si materializzò sulla trigonometrica visuale del mirino la figura autoritaria del vecchio Rinaldi. La testa magra, quasi appuntita, la pelle curata del viso, tesa, decorata di botox e lampade. Aveva una giovane accanto – bellissima, doveva essere una modella straniera – e delle guardie del corpo grosse come vichinghi. Dettagli irrilevanti per Stefano. Gli interessava solo quella testa. Interesse rapido comunque. Un altro aspetto fondamentale del suo lavoro era la velocità.
Trascorse forse un secondo e mezzo. La testa di Goffredo Rinaldi si aprì come un fiore, come una pianta carnivora tropicale: succosa, colorata. In un tempo minuscolo la mente più vivida e oscura dell’economia del Paese degli ultimi decenni si era fatta mostra di sé nella maniera più cruda, aperta alla stregua di un frutto maturo. Esplosa tra le urla dei passanti, tra il via vai incontrollato di quei gorilla in giacca e cravatta, e il terrore di una giovane donna bellissima, che probabilmente stava gridando aiuto. Ma Stefano non sentiva niente. Da lontano – erano svariate centinaia di metri, forse un chilometro – quelle urla erano solo movimenti compressi in un mirino.
Con altrettanta velocità, Stefano smontò il fucile, lo risistemò con cura nella valigia e lo lasciò nascosto sotto l’ampio bordo del tetto. Quando avrebbero trovato il fucile lui sarà stato via da tempo. Era stato un lavoro preciso, veloce, concreto, pulito. Un lavoro da migliore sulla piazza.
“Una tragedia”, così avrebbe titolato il Corriere l’indomani. Ci sarebbero stati approfondimenti, prima nel bene, decorandolo come il cervello più fine e scaltro dell’economia italiana. Poi ci sarebbero stati gli approfondimenti sulle sue presunte amicizie con la malavita e sul coinvolgimento di quest’ultima nel suo omicidio. Ma poi è poi e nessuno ci avrebbe più pensato più di tanto. Di certo non Stefano. “Uno in meno”, dissero i maligni, i cinici, gli invidiosi dei ricchi. Ma per Stefano era solo uno in più. Una tacca in più sul suo curriculum da sicario. Solo una tacca in più, un’altra commissione portata a termine, un altro lavoro a cottimo a svariati zeri. Un giorno di lavoro in più, solo uno in più. Un giorno in più a nascondersi, a muoversi veloce tra le trame più oscure della società. Uno in più a non parlare con Veronica, perché no, quel mormorio non era fatto di parole; a non riuscirla a guardare nemmeno in faccia, neanche per un istante, perché lo sapeva bene Stefano: quello sarebbe stato il rischio più grande della sua vita.
Pensò a tutto questo Stefano. Ci pensò per dei secondi. Poi estrasse il cellulare. Scrisse un sms: “Fatto”. Lo inviò a R.. A lavoro finito scriveva sempre e solo questo: fatto. Era un altro sms, uguale a tutti gli altri: nient’altro che uno in più.
Pierpaolo de Flego